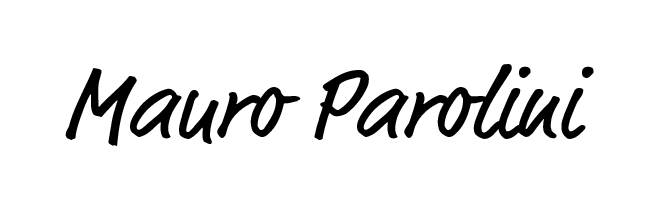Caro direttore, in questi ultimi mesi si è aperto nel nostro Paese un appassionante dibattito scaturito dal progetto del premier inglese Cameron definito «The Big Society». Parimenti, negli Usa, dove si parla di un «Philantropic Big Bang», l’ ipotesi è al centro di grande interesse e fermento. La formula consiste, in sintesi, nel ridurre l’ intervento dello Stato nel sociale a tutto vantaggio di quel terzo settore o «terzo pilastro», come scrivo da anni, che ha già un peso economico rilevante nel mondo (20 milioni di occupati in Europa, dei quali oltre 1 milione e 300 mila in Italia; e negli Usa dove rappresenta il 2,2% del Pil). A mio avviso è possibile sperimentare la Big Society anche in Italia, a condizione di sgombrare il campo dall’ equivoco su cosa debba intendersi per società civile. Essa non è quella elitaria dei «salotti», né quella delle lobby più o meno trasparenti, bensì quella costituita dall’ insieme di persone che, singolarmente o in forma associata, si dedicano alla costruzione del bene comune. Questa è la vera società civile, che in Italia ha una storia antica, che affonda le radici nella tradizione cristiana, come in quella laica e socialista, e che rappresenta, a mio giudizio, il più importante patrimonio di risorse, di idee, di energie, a cui attingere per dare una svolta al nostro Paese e condurlo verso uno sviluppo equilibrato, e che abbia comunque al centro il primato dell’ uomo. Nella storia nazionale la classe politica è stata sempre avversa a questo mondo, in quanto, a partire dal Risorgimento, ove prevalse un liberalismo di stampo statalista, i governi che si sono succeduti hanno duramente contrastato la partecipazione della società civile alla gestione della cosa pubblica. Accadde con la legge Crispi del 1890, poi sistematicamente durante il regime fascista, portatore di una concezione di Stato centralista, ed è stato così persino nell’ Italia repubblicana e democratica. Soltanto con la riforma del dettato costituzionale dell’ art. 118 del 2001, che ha introdotto il principio di sussidiarietà, si è cominciato a ribaltare l’ impostazione culturale sfavorevole alle iniziative dal basso, per sposare una concezione indirizzata verso l’ essenzialità del contributo della società civile. La possibilità che lo Stato riduca il proprio impegno e, conseguentemente, gli oneri in alcuni settori come la sanità, la scuola, i servizi alla persona, la cultura, a vantaggio dell’ autonoma iniziativa della collettività in grado di garantire analoghe prestazioni è, a grandi linee, il mio convincimento da sempre, che ritrovo nel progetto della Big Society, riproposto in questo contesto di crisi, proprio per reagire ad essa senza ridurre le garanzie sociali. Sulla proposta sono emerse autorevoli posizioni critiche, che ritengono irrealizzabile in Italia la possibilità di sperimentare efficacemente detta formula perché mancherebbero le condizioni preliminari necessarie, e cioè: una cultura politica favorevole e un capitale sociale dinamico e attivo; delle organizzazioni intermedie orientate al bene collettivo e non ai vantaggi corporativi; uno Stato efficiente e non invasivo. Si sostiene poi che è proprio lo Stato che in definitiva avrebbe il compito di supportare i corpi intermedi e di generare i costi necessari che, probabilmente, non sarebbero inferiori a quelli sostenuti attualmente direttamente dallo Stato. Sono critiche facilmente controbattibili. Innanzitutto poiché la classe politica ha preso atto, seppur con riluttanza, dell’ impossibilità di continuare a pretendere di fare ed occupare ogni spazio data la scarsità delle risorse e, quindi, un’ eventuale sua battaglia di retroguardia sarebbe sicuramente perdente. E poi perché non è affatto vero che è lo Stato che si fa carico dell’ attività dei corpi intermedi, e le fondazioni di origine bancaria ne sono la palese testimonianza, come non è vero che in Italia non esista un tessuto civile favorevole alla sperimentazione della Big Society, poiché, anzi, storicamente ne abbiamo la primogenitura. Ritengo, dunque, che anche nel nostro Paese si possa dar vita a un progetto non dissimile da quello inglese, e non solo per la nostra storia, ma anche perché l’ enorme deficit di bilancio dello Stato e la necessità di mantenere un livello di garanzie sociali adeguato lo impongono. Secondo me, come ho scritto, «il terzo pilastro», il mondo del non profit può essere «motore del nuovo welfare», e può favorire una significativa riduzione della spesa pubblica e, di conseguenza, del prelievo fiscale, liberando risorse per lo sviluppo. Perché l’ esperimento possa avere successo in Italia occorre, tuttavia, porre in atto alcuni interventi di riforma, tra i quali, prioritariamente, l’ ampliamento dell’ interpretazione dell’ art. 118 della Costituzione, che rafforzi il principio di sussidiarietà, e l’ avvio della la riforma del codice civile sulle persone giuridiche, con il conseguente adeguamento del regime fiscale agli standard europei in materia di non profit. D’ altra parte, anche il mondo del non profit deve fare un salto qualitativo arrivando a una piena maturazione e presa di coscienza dei maggiori compiti cui è chiamato, e a un miglioramento significativo della sua efficienza organizzativa. Se così sarà, anche il nostro Paese vivrà una nuova stagione di prosperità. Presidente Fondazione Roma
Emanuele Emmanuele