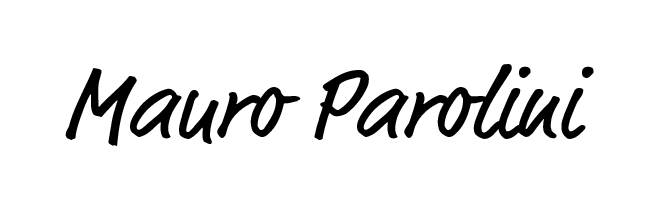“In Europa si decide molto non solo del nostro futuro, ma anche della nostra vita di tutti i giorni. Esserci con una presenza qualificata, decidere chi mandare, scegliere chi ci governa è fondamentale. Non andare a votare il 26 maggio vuol dire non volersi occupare della propria vita”.
Vi riporto qui sotto l’intervisa con Marco Biscella de IL SUSSIDIARIO.
Partiamo proprio da qui. Lei si candida in un partito, Forza Italia, che aderisce al Ppe, uno dei gruppi che storicamente ha guidato e guida l’Europa. Ma oggi molti cittadini europei chiedono un cambio di passo alla Ue. Come si possono conciliare tradizione e cambiamento? E soprattutto: in cosa deve consistere il cambiamento?
Qualche esempio?
In termini molto sintetici, ne cito tre: l’Europa costituisce il principale mercato di sbocco delle nostre merci, visto che assorbe il 60% del nostro export di beni e servizi; l’80% dei turisti che vengono in Italia arriva dai Paesi europei; la Bce negli ultimi anni con il Quantitative easing di Mario Draghi ha contribuito a salvare i nostri conti pubblici e la nostra economia. E soprattutto: è giusto riconoscere che la pace in Europa in questi 70 anni non è arrivata per caso, bensì è frutto dell’intuizione di tre grandi statisti che negli anni Cinquanta hanno scelto di costruire le ragioni e le strutture che potessero garantire pace e prosperità anziché continuare a farsi la guerra come successo nei precedenti 200 anni. Quindi, il dato di partenza è che l’Europa ci serve. Ma oggi c’è bisogno di un cambio di passo.
In che direzione?
Se vuole essere utile in uno scenario mondiale in profondo mutamento, l’Europa deve essere più forte, il che significa, innanzitutto, avere una politica estera comune, almeno sulle grandi questioni internazionali e globali, e in secondo luogo, tema di cui si parla poco ma che già De Gasperi aveva ben chiaro, avere una politica di difesa comune, che serve a garantire la sicurezza. Terzo: una nuova politica dell’immigrazione, a partire dall’integrazione di chi già vive in Europa. Quanto ai flussi migratori, noi oggi li teniamo sotto controllo, ma il tumultuoso trend di crescita demografica dell’Africa impone di adottare politiche proattive, tali da garantire una cooperazione allo sviluppo che non può essere accollata a un singolo Paese, ma va assunta a livello comunitario. E poi va cambiato il Trattato di Dublino: chi entra in un Paese europeo, specie se esposto ai flussi come il nostro, entra in Europa.
In discussione, soprattutto ma non solo in Italia, ci sono le regole dell’euro. Secondo lei, cambiarle è auspicabile, possibile o irrinunciabile?
La stabilità monetaria è decisiva. E’ bene che l’euro diventi sempre più lo strumento per una crescita più equilibrata tra i diversi Paesi. E’ chiaro che per un Paese come l’Italia, che ha un debito pubblico superiore al 130% del Pil, è meglio fare deficit per favorire la crescita piuttosto che per finanziare misure assistenzialistiche. Le regole servono, ma adesso devono essere calibrate per poter puntare in modo prevalente sullo sviluppo e sulla crescita del lavoro.
Oggi esistono almeno due Europe, se non di più. Come si può colmare la faglia tra Nord e Sud dell’Europa, in un’epoca in cui sembrano prevalere gli egoismi nazionali?
Bisogna trovare le convenienze di fondo, che mi rifiuto di pensare non ci siano. Puntare a un orizzonte condiviso, a una crescita stabile, a una collaborazione efficace e proficua nel tempo è conveniente per tutti. Il metodo dunque è semplice: andare a cercare le convenienze e gli interessi in comune. Almeno bisognerebbe provarci, passando magari da una dialettica e da una ricerca faticosa di mediazioni. Anche perché, per esperienza, quando si ignorano le necessità degli altri e si pensa di fare il proprio interesse, alla lunga – e l’Europa speriamo duri ancora a lungo – ci si fa solo del male. Serve, più che un’azione politica, un salto culturale, che conviene anche ai Paesi del Nord Europa.
In Europa prevalgono paura, chiusura e diffidenze. Come la politica può aiutare a ritrovare slancio, a galvanizzare un continente che appare vecchio e stanco?
La paura è diffusa, spesso anche motivata, e non mi sento di ignorarla. Ansie e preoccupazioni dei cittadini vanno prese sul serio. Ci sono però due modi di superarle. Il primo è individuare un nemico, che magari cambia di giorno in giorno – una volta è l’Europa, un’altra sono gli immigrati, un’altra ancora qualcos’altro – e cercare di abbatterlo, illudendosi che così la paura passa, in realtà il giorno dopo ritorna uguale.
E l’altro modo?
E’ il metodo che ha seguito mio padre: non era un industriale, ma faceva il camionista, e avendo sei figli da tirare grandi avrà avuto sicuramente ansie, paure e preoccupazioni legate alla famiglia, al futuro. Ma aveva una speranza: non ignorando la realtà, ma proprio dentro le circostanze della vita, aveva la speranza di costruire un futuro migliore. L’Europa può avere un futuro solo se supera la paura e ritrova la speranza.
Ma dove sta oggi questa speranza per l’Europa?
Per guardare avanti bisogna guardare un po’ indietro. Che cosa ha animato Schuman, Adenauer e De Gasperi? L’idea che l’Europa avesse delle radici comuni, le radici cristiane. Cioè, che qui in Europa, anche se motivi per lamentarsi non mancheranno mai, di certo abbiamo sistemi democratici, rispetto della persona, attenzione a non lasciare nessuno indietro: princìpi, valori ed esperienze che vanno rilanciati e difesi. La speranza poggia su un solido terreno, che è la nostra storia, l’eredità che abbiamo ricevuto. La società liquida si può rendere più solida, resistente e resiliente riconoscendo e favorendo le esperienze positive e i rapporti utili e stabili tra chi si mette insieme per costruire il bene comune.
La Ue rappresenta il 7% della popolazione mondiale, il 25% del Pil e il 50% del welfare. In questi tre numeri sono racchiuse tre sfide epocali dell’Europa: denatalità, sviluppo e lavoro, tenuta di tutele e diritti sociali. Come affrontarle?
Primo punto: non possiamo rassegnarci a essere sempre di meno. Ma sulle dinamiche demografiche, specie nel nostro Paese che ha tassi di natalità tra i più bassi d’Europa, oltre a un problema culturale – se si ha paura del futuro difficile fare figli – c’è anche il tema di come si sostengono le famiglie: meglio intervenire sugli assegni famigliari che sul reddito di cittadinanza. E può essere utile anche dare un aiuto effettivo sulla conciliazione famiglia-lavoro. Secondo punto: senza sviluppo non c’è lavoro e lo sviluppo non può essere disgiunto dal lavoro, anzi deve essere uno sviluppo tecnologico che si porta dietro lavoro qualificato e ben remunerato. Terzo punto: aumenta la domanda di welfare, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione, ma diminuiscono le risorse.
Come uscirne?
Non possiamo certo rinunciare all’universalità, come negli Stati Uniti, che su questo sono più avanti, cioè più indietro: là lo Stato ti cura se hai i soldi o appartieni a qualche categoria. Occorre allora puntare a un welfare più sussidiario, che coinvolge le comunità e le imprese, in grado di offrire servizi migliori, perché più attenti ai bisogni delle persone, e meno costosi.
Nel nostro Paese c’è ancora un 30% di elettori indecisi e storicamente il tasso di partecipazione al voto per le Europee è più basso rispetto alle elezioni politiche. Perché è importante andare a votare il prossimo 26 maggio?
Perché in Europa si decide molto non solo del nostro futuro, ma anche della nostra vita di tutti i giorni. Esserci con una presenza qualificata, decidere chi mandare, scegliere chi ci governa è fondamentale. Non andare a votare il 26 maggio vuol dire non volersi occupare della propria vita.
E perché, secondo lei, un elettore dovrebbe preferire una forza politica europeista a una sovranista?
L’Europa si governa, e si difende meglio l’interesse dell’Italia, se si va d’accordo con gli altri. Il Ppe è un gruppo in cui siedono grandi partiti di grandi Paesi, è un ambito in cui si può fare una sintesi efficace. I sovranisti, invece, una volta usciti dai propri confini, trovano altri sovranisti che fanno prevalere altri interessi. Su tutte le grandi questioni decisive del nostro Paese, come l’immigrazione, quando c’è stato bisogno di dare una mano all’Italia, i primi a dir di no sono stati i Paesi con leader sovranisti.